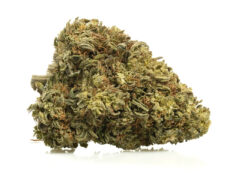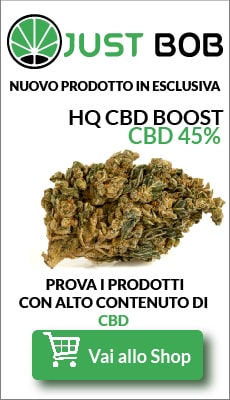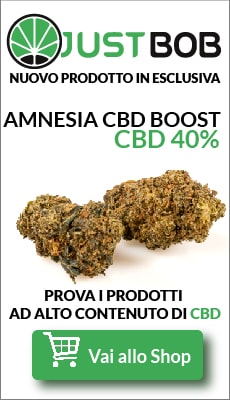Modificato il: 15/08/2025
Si tratta di un fenomeno documentato in contesti clinici controllati, studiato per il suo potenziale terapeutico ma anche per i significativi rischi psicologici che comporta
Il concetto di morte dell’ego è un termine utilizzato per descrivere un’esperienza soggettiva riportata in diversi contesti, ma che riceve particolare attenzione quando associato agli effetti di alcune sostanze psichedeliche. Queste sostanze sono note per la capacità di indurre stati di coscienza profondamente alterati, i quali possono includere la sensazione di una dissoluzione dei confini del sé individuale.
Oggi su Justbob ci proponiamo di esaminare il fenomeno descritto come “morte dell’ego” nel contesto degli studi sugli psichedelici. Analizzeremo il significato attribuito a questa espressione, le ipotesi sui meccanismi neurobiologici sottostanti e le possibili conseguenze psicologiche, basandoci sulle conoscenze scientifiche attuali, che comprendono sia l’esplorazione di potenziali applicazioni terapeutiche in contesti clinici rigorosi, sia l’identificazione di rischi intrinseci significativi.
Mentre l’esplorazione di tali stati alterati comporta avvertenze importanti, è fondamentale distinguere nettamente queste sostanze da prodotti legali derivati dalla canapa, come la cosiddetta cannabis light, apprezzata per scopi consentiti dalla legge (come collezionismo o profumazione d’ambiente) e priva degli effetti psicoattivi qui discussi.
L’ego in psicologia: la struttura messa in discussione
Per capire in che modo alcune sostanze possano modificare la percezione che abbiamo di noi stessi, è utile partire da cosa intendiamo con la parola “ego”.
Secondo la psicoanalisi di Freud, l’ego è quella parte della mente che cerca di tenere insieme i nostri impulsi, le regole sociali e la realtà quotidiana: è ciò che ci fa sentire un “io” stabile. Per Jung, l’ego è il centro della nostra coscienza, ma esiste all’interno di una dimensione più profonda e vasta, che lui chiama il “Sé”. Le teorie psicologiche più recenti, invece, vedono l’ego come un insieme di funzioni mentali – come la memoria, l’autoconsapevolezza e la capacità di riflettere su sé stessi – che costruiscono quella che chiamiamo identità personale.
In tutti questi casi, l’ego può essere inteso come ciò che mantiene il nostro senso di essere un individuo separato, con confini ben definiti rispetto al mondo e agli altri. Ed è proprio questo equilibrio che, secondo molti studi, può essere temporaneamente alterato da alcune sostanze psichedeliche.
L’ipotesi su cui si sta concentrando la ricerca scientifica è che queste sostanze, modificando l’attività di alcuni neurotrasmettitori nel cervello, riescano ad allentare i meccanismi che tengono insieme la nostra identità abituale. Quando ciò accade, si può provare una strana – e a volte profonda – sensazione di dissoluzione dell’ego, come se i confini tra sé e il mondo si facessero più labili o svanissero del tutto.
Si tratta di un fenomeno complesso, su cui la scienza sta ancora cercando di fare piena luce, per capirne non solo i meccanismi biologici ma anche le implicazioni psicologiche ed esistenziali.
Leggi anche: THC & cervello: effetti e danni a breve e lungo termine


Contesto storico: dalle pratiche contemplative agli psichedelici
L’idea di andare oltre i confini del proprio ego non è una novità recente: da secoli è presente in molte tradizioni spirituali e filosofiche. Pratiche come la meditazione buddista, che mira a realizzare il principio del non-sé (Anatta), oppure certi percorsi dello yoga induista e le esperienze mistiche descritte in diverse religioni, sono tutte strade che mirano a ridurre il peso dell’ego e a vedere la realtà da una prospettiva più ampia. In questi casi, però, il processo è graduale, richiede tempo, disciplina e un lungo lavoro interiore.
L’associazione tra una dissoluzione improvvisa e profonda dell’ego e l’uso di sostanze psichedeliche, invece, è qualcosa che appartiene alla storia recente, in particolare al XX secolo. Dopo la scoperta dell’LSD e della psilocibina negli anni ’40 e ’50, molti ricercatori iniziarono a esplorarne gli effetti sulla mente. In quel periodo, si cominciò a pensare che queste sostanze potessero avere un valore terapeutico, ma anche essere strumenti per espandere la coscienza al di là dei limiti abituali.
Fu un periodo di grande entusiasmo, ma anche di crescente preoccupazione sociale. A un certo punto, la reazione politica e culturale portò a un blocco quasi totale della ricerca scientifica, e gli psichedelici vennero fortemente stigmatizzati e resi illegali in molti paesi.
Solo negli ultimi decenni la scienza ha ripreso con cautela a studiarli, attraverso studi clinici molto controllati, condotti in ambienti sicuri e sotto supervisione medica e psicologica. Questa nuova fase – spesso chiamata “rinascita psichedelica” – si concentra soprattutto sul possibile impiego terapeutico di queste sostanze in casi di depressione, ansia, disturbo post-traumatico e altre condizioni resistenti ai trattamenti tradizionali. Allo stesso tempo, gli studiosi cercano di comprendere meglio anche le esperienze interiori intense che possono emergere, tra cui quelle che trasformano profondamente il modo in cui una persona percepisce sé stessa.
Descrizione fenomenologica: caratteristiche riportate dell’esperienza
Descrivere in modo oggettivo ciò che viene comunemente chiamato “morte dell’ego”, quando indotta da sostanze psichedeliche, è piuttosto complesso. Si tratta di un’esperienza profondamente soggettiva e spesso descritta come ineffabile, cioè difficile da esprimere a parole. Tuttavia, studi condotti in ambito clinico e i resoconti raccolti in contesti di ricerca hanno permesso di individuare alcune caratteristiche ricorrenti, pur nella grande varietà individuale.
Tra gli elementi più frequentemente osservati c’è la percezione di una dissoluzione dei confini tra sé e il mondo esterno. La distinzione tra “io” e ambiente può affievolirsi fino a scomparire, lasciando emergere un senso di fusione o interconnessione con ciò che circonda. A questo tipo di vissuto si accompagnano spesso alterazioni sensoriali marcate, come visioni vivide, suoni amplificati o percezioni sinestetiche (in cui i sensi si mescolano). Anche il tempo può essere percepito in modo radicalmente diverso, come se si dilatasse, si arrestasse o perdesse del tutto significato.
Sul piano emotivo, le reazioni documentate spaziano da stati di calma profonda, stupore o estasi, fino a episodi di forte ansia, paura o disorientamento, specie nei casi in cui l’esperienza viene vissuta come una perdita di controllo.
Molti racconti includono il tema della “morte simbolica” dell’identità abituale, vissuta come una forma di azzeramento temporaneo del senso di sé.
È importante sottolineare che la natura e l’intensità di queste esperienze dipendono da numerosi fattori: la sostanza utilizzata, la dose, le caratteristiche psicologiche individuali, e il contesto in cui l’esperienza avviene — un concetto noto in ambito scientifico come “set and setting”. Questi elementi influenzano profondamente non solo la qualità dell’esperienza, ma anche il suo possibile impatto psicologico a lungo termine.
Inoltre, è interessante notare come l’esperienza psichedelica possa indurre reazioni emotive così polarizzate, inclusa una forte ansia; un effetto nettamente diverso da quello ricercato in altri derivati della canapa, come l’olio di CBD, che viene studiato per le sue potenziali proprietà rilassanti e di gestione dell’ansia, agendo però su meccanismi biologici differenti e senza indurre stati di coscienza alterati o perdita di controllo.
Ipotesi neurobiologiche: cosa succede nel cervello?
Negli ultimi anni, la ricerca neuroscientifica ha iniziato a esplorare come funzionano il cervello e la coscienza durante gli stati indotti da sostanze psichedeliche, usando strumenti avanzati come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e l’elettroencefalogramma (EEG). Uno degli aspetti più studiati riguarda cosa accade nel cervello quando una persona vive l’esperienza della dissoluzione dell’ego.
Un’area chiave su cui si concentrano molti studi è il cosiddetto Default Mode Network (DMN), una rete di regioni cerebrali coinvolte nell’auto-riflessione, nella memoria autobiografica e nel modo in cui costruiamo il nostro senso di identità. I ricercatori hanno osservato che, sotto l’effetto di sostanze come LSD o psilocibina, questa rete mostra una diminuzione dell’attività e della coerenza interna: in altre parole, il DMN funziona in modo meno integrato. Secondo alcune ipotesi, proprio questa “disorganizzazione” temporanea del DMN potrebbe contribuire alla sensazione soggettiva di perdita del senso del sé.
Allo stesso tempo, altri studi suggeriscono che durante questi stati si verifica un aumento delle connessioni tra parti del cervello che normalmente comunicano poco tra loro. Questo porta a una condizione di maggiore “fluidità” mentale, in cui i pensieri scorrono in modo meno lineare e più creativo, e le percezioni diventano più intense e particolari. Alcuni scienziati definiscono questo stato come più entropico, cioè caratterizzato da un’attività cerebrale più libera e meno organizzata rispetto alla normalità.
Tutti questi effetti sembrano legati in larga parte all’attivazione di specifici recettori della serotonina, in particolare quelli chiamati 5-HT2A, che giocano un ruolo centrale nell’azione degli psichedelici classici.
Tuttavia, anche se abbiamo iniziato a comprendere alcuni meccanismi biologici, la relazione tra ciò che accade nel cervello e le esperienze soggettive vissute da chi assume queste sostanze resta ancora in gran parte un mistero. La scienza sta ancora cercando di capire come tradurre i dati neurologici in una comprensione più completa delle esperienze interiori complesse che queste sostanze possono generare.
Morte dell’ego: esperienze tra Default Mode Network, trascendenza e filosofia
L’esperienza della morte dell’ego rappresenta, a più di una volta, un punto di contatto tra neuroscienze, psicologia, filosofia e tradizioni spirituali. Dal punto di vista neurobiologico, la riduzione dell’attività del Default Mode Network (DMN) è alla base di molte delle sensazioni di dissoluzione del sé, portando a una temporanea connessione e unità con ciò che ci circonda. In un certo senso, questa sospensione dei consueti schemi mentali agisce come una riduzione della distanza percettiva tra il soggetto e il mondo, alterando la percezione di spazio-tempo e scardinando la consueta consapevolezza ordinaria.
Nel settore della ricerca psichedelica, pionieri come Timothy Leary hanno raccontato storie in cui l’uso di determinate droghe non era solo un atto sperimentale, ma una porta verso illuminazione e trascendenza. Allo stesso tempo, pensatori come Carl Jung hanno offerto interpretazioni simboliche: per lui, la dissoluzione dell’ego poteva essere letta come un ritorno al Sé più profondo, un processo di partenza dalla separazione e di ritorno a un’unità interiore.
In Occidente, tuttavia, questa prospettiva si è scontrata con un problema culturale: il bisogno di controllo e stabilità si oppone al contrario stato di fluidità e apertura mentale che queste esperienze generano. A livello narrativo e letterario, diversi libri e articoli italiani hanno discusso il tema, talvolta celebrando la possibilità di un salto di coscienza, talvolta mettendo in guardia dai rischi legati a un uso improprio.
Che si tratti di una ricerca di senso nella vita o di un’indagine sperimentale, la morte dell’ego resta un fenomeno capace di generare dibattito e riflessione, invitando a ripensare il pensiero stesso e il network di convinzioni che lo sostengono. È un’esperienza che può affascinare o spaventare, ma che, in ogni caso, mette in discussione il default stesso della nostra identità.


Sostanze coinvolte e importanti distinzioni
È importante chiarire che l’esperienza della cosiddetta “morte dell’ego” è documentata principalmente nel contesto dell’uso di psichedelici classici (o serotoninergici), come LSD, psilocibina, DMT e mescalina. Queste sostanze, se assunte in condizioni appropriate e a dosaggi adeguati, possono indurre stati di coscienza profondamente alterati, nei quali il senso abituale di identità personale può temporaneamente dissolversi. Tale fenomeno, pur variabile da individuo a individuo, è stato ampiamente descritto sia nella letteratura scientifica sia nei resoconti esperienziali, e costituisce una delle caratteristiche più peculiari e trasformative di queste sostanze.
Se ci si sposta oltre gli psichedelici classici, viene spesso citato anche il THC, principio attivo della cannabis, che in alcune circostanze può generare esperienze soggettive vagamente simili, almeno in forma attenuata o transitoria. Ciò può verificarsi soprattutto con dosi elevate, in persone particolarmente sensibili o in contesti che favoriscono un’introspezione profonda (come l’isolamento, il digiuno o stati meditativi). Tuttavia, si tratta di situazioni rare e poco strutturate, in genere molto diverse dalle esperienze più articolate e trasformative associate ai composti psichedelici veri e propri.
Più frequentemente, alti dosaggi di THC provocano dissociazioni parziali, stati di confusione, ansia o derealizzazione, che possono essere scambiati per fenomeni di perdita dell’ego, pur non condividendone la qualità integrativa. È quindi fondamentale non assimilare superficialmente questi stati a quelli indotti dai veri psichedelici.
Proprio alla luce di queste differenze, è importante non confondere gli effetti del THC con quelli di altri prodotti derivati dalla cannabis, come la cosiddetta cannabis light, oggi largamente diffusa in Italia. Questi derivati della pianta di canapa (come l’olio di CBD o la cosiddetta erba legale) sono regolamentati dalla legge e venduti unicamente per usi specifici come collezionismo, ricerca, impiego tecnico o profumazione d’ambiente, escludendo il consumo umano. Contengono principalmente CBD (cannabidiolo) e livelli di THC estremamente ridotti, ben al di sotto delle soglie psicoattive.
Il CBD, infatti, non è una sostanza psichedelica né produce alterazioni significative della coscienza. La sua azione sul sistema nervoso si manifesta, piuttosto, attraverso modulazioni sottili legate al rilassamento, all’attenuazione dell’ansia o all’effetto antinfiammatorio, senza coinvolgere la percezione di sé o la struttura dell’identità personale. Di conseguenza, l’assunzione di CBD non può essere associata ad alcuna forma di dissoluzione dell’ego, né lieve né profonda.
Distinguere tra queste sostanze — per composizione, effetti e contesto d’uso — è fondamentale per evitare fraintendimenti e interpretazioni improprie, soprattutto quando si affrontano temi complessi come la trasformazione del sé o gli stati non ordinari di coscienza.
Valutazione complessiva: potenziali effetti e rischi significativi
Per valutare in modo equilibrato l’esperienza di morte dell’ego indotta da psichedelici, è importante considerare sia i possibili benefici psicologici oggetto di ricerca, sia i rischi concreti che può comportare.
Da un lato, alcuni studi clinici preliminari, condotti in ambienti altamente controllati come ospedali e università e sempre sotto stretta supervisione medica, stanno cercando di capire se queste esperienze – se ben gestite – possano avere effetti terapeutici positivi. Le ricerche si concentrano su condizioni complesse come la depressione resistente, il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) o l’ansia esistenziale legata, ad esempio, a diagnosi gravi. In alcuni casi, i partecipanti hanno riportato miglioramenti nei sintomi e una maggiore sensazione di benessere psicologico.
È importante sottolineare che si tratta di studi ancora sperimentali, condotti secondo protocolli molto rigorosi. Questi includono una selezione accurata dei partecipanti, una preparazione psicologica, il supporto durante l’esperienza e un processo di integrazione successivo per aiutare a elaborare ciò che è stato vissuto.
Dall’altro lato, però, anche in contesti controllati – e ancor più al di fuori di essi – l’esperienza può trasformarsi in qualcosa di psicologicamente destabilizzante se non viene gestita con attenzione. Alcune persone possono vivere episodi acuti di panico, paranoia, terrore o perdita di controllo, con un impatto emotivo anche molto intenso. Inoltre, in soggetti con una predisposizione genetica o una storia clinica di disturbi psichiatrici (come psicosi o disturbo bipolare), l’uso di psichedelici può favorire l’emergere di queste condizioni o anticiparne l’esordio, anche se fino a quel momento non si erano manifestate in modo evidente.
Tra gli altri rischi noti ci sono anche la possibilità di sviluppare alterazioni percettive persistenti (note come HPPD) o stati prolungati di disagio psicologico dopo l’esperienza.
Per questo motivo, la questione della sicurezza è centrale. L’uso di queste sostanze fuori da un contesto medico o terapeutico autorizzato, e senza una supervisione adeguata, comporta rischi elevati e non dovrebbe mai essere preso alla leggera.
Leggi anche: Uno sguardo agli effetti del CBD sul cervello
Comprendere la complessità degli stati alterati
L’espressione “morte dell’ego” nel contesto degli studi sugli psichedelici descrive un’esperienza soggettiva complessa, caratterizzata da una temporanea dissoluzione del senso di sé abituale e dei confini percepiti tra individuo e mondo.
Questo fenomeno, associato all’azione di psichedelici classici sul cervello è oggetto di indagine scientifica per comprendere meglio la coscienza e valutare potenziali applicazioni terapeutiche future, esclusivamente all’interno di protocolli di ricerca clinica rigorosi e autorizzati.
È tuttavia essenziale approcciare questo argomento con estrema cautela e oggettività, riconoscendo la potenza di queste esperienze e i significativi rischi psicologici documentati, specialmente al di fuori di contesti supervisionati.
La comprensione di questo fenomeno richiede un approccio informato, critico e focalizzato sulla sicurezza, consapevole della complessità degli stati alterati di coscienza e delle implicazioni legate all’uso di queste potenti sostanze al di fuori di percorsi di ricerca scientifica o clinica approvati.