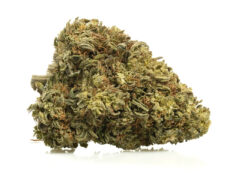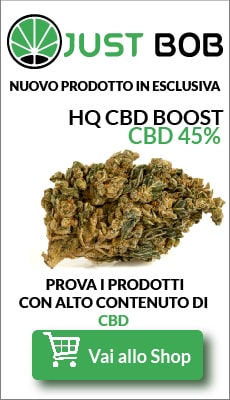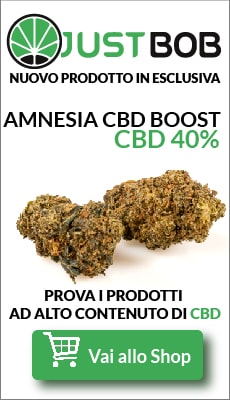Pubblicato il: 22/09/2025
Una pianta, due volti: perché il kratom è al centro di un dibattito globale che ci riguarda da vicino, simile a quello sulla cannabis
Poche piante hanno suscitato un interesse e un dibattito intensi come il kratom, il cui nome scientifico è Mitragyna speciosa. Originario delle lussureggianti foreste del Sud-est asiatico, è un albero sempreverde appartenente alla stessa famiglia del caffè, le Rubiaceae. Per secoli, le sue foglie sono state parte integrante delle culture tradizionali di paesi come la Thailandia, la Malesia e l’Indonesia, utilizzate da contadini e lavoratori per le loro peculiari proprietà. Oggi, il kratom è oggetto di studio scientifico, di discussione normativa e di curiosità da parte di un pubblico sempre più attento alle sostanze di origine naturale.
Non si tratta di una sostanza semplice da etichettare, dato che i suoi effetti sono notoriamente dose-dipendenti, capaci di manifestarsi in modi quasi opposti a seconda della quantità assunta: questa è una delle principali sfide per la scienza e la regolamentazione.
L’obiettivo di questo approfondimento è fornire una panoramica chiara, oggettiva e soprattutto scientifica su questa pianta, analizzandone le origini, la composizione chimica, i meccanismi d’azione e il contesto in cui si inserisce oggi. In un’epoca in cui l’interesse per composti naturali come quelli derivati dalla canapa sativa è in forte crescita, esplorare il kratom con un approccio rigoroso è fondamentale per distinguere i fatti dalle speculazioni.
Esploreremo come l’uso tradizionale, spesso basato sulla masticazione delle foglie fresche, si sia trasformato nelle moderne preparazioni in polvere o estratti. Analizzeremo gli alcaloidi responsabili dei suoi effetti, in particolare la mitraginina e la 7-idrossimitraginina, e il loro peculiare modo di interagire con i recettori del nostro corpo.
Leggi anche: 6 curiosità sulla cannabis che (forse) ancora non conoscevi
Le origini botaniche e storiche del kratom
La nostra conoscenza del kratom parte dalle sue radici, sia in senso letterale che figurato. Come accennato, la Mitragyna speciosa è un imponente albero tropicale che può raggiungere altezze superiori ai 25 metri. Prospera nei climi caldi e umidi del Sud-est asiatico, con un habitat naturale che si estende dalla Thailandia alla Malesia, passando per l’Indonesia, il Borneo e Papua Nuova Guinea.
Nelle sue foglie, di un verde intenso e lucido, si concentra la ricca gamma di composti attivi, noti come alcaloidi, che conferiscono alla pianta le sue celebri proprietà. La sua appartenenza alla famiglia delle Rubiaceae la rende una “cugina” della pianta del caffè, che suggerisce una predisposizione biochimica alla produzione di alcaloidi stimolanti.
L’uso del kratom è documentato da secoli nelle comunità rurali di queste regioni. Tradizionalmente, non era considerato una sostanza ricreativa nel senso moderno del termine, ma piuttosto uno strumento di lavoro e un rimedio popolare. I lavoratori manuali, come agricoltori, pescatori e braccianti, erano soliti masticare le foglie fresche di kratom durante le giornate di lavoro. A basse dosi, la pianta manifestava effetti stimolanti, simili a quelli di una forte tazza di caffè, aiutando a combattere la fatica, aumentare la resistenza e migliorare l’umore e la socialità.
In dosi più elevate, le proprietà del kratom cambiavano radicalmente: gli effetti erano sedativi, analgesici e di rilassamento muscolare. Questa “seconda natura” della pianta la rendeva un rimedio utile nella medicina tradizionale per alleviare dolori di varia natura o come coadiuvante del sonno.
Una forma di consumo tradizionale era la preparazione di un infuso, un “tè di kratom”, ottenuto facendo bollire le foglie fresche o essiccate. La bevanda veniva spesso consumata in contesti sociali, al termine della giornata lavorativa, in modo simile a come in altre culture si condivide un bicchiere di vino o una birra. In passato, veniva utilizzata la foglia intera e non lavorata, una differenza sostanziale rispetto ai moderni estratti concentrati che possono presentare un profilo di rischio differente. Questo contesto storico e culturale è fondamentale per capire come una pianta integrata in una società possa assumere significati e implicazioni diverse quando viene decontestualizzata e introdotta in mercati globali.


Kratom: composizione chimica e meccanismi d’azione
La chiave per decifrare l’attività biologica del kratom risiede nella sua fitochimica. Le foglie di questa pianta contengono oltre 40 alcaloidi diversi, ma due di essi sono considerati i principali responsabili dei suoi effetti farmacologici: la mitraginina e la 7-idrossimitraginina.
La mitraginina è l’alcaloide più abbondante: costituisce fino al 66% del contenuto totale di alcaloidi in alcune varietà di kratom thailandese. La 7-idrossimitraginina, sebbene presente in concentrazioni molto più basse (meno del 2%), è più potente della mitraginina dal punto di vista dell’attività biologica. La variabilità nella concentrazione di questi e altri alcaloidi, influenzata da fattori come la regione di crescita, l’età della pianta e il periodo di raccolta, spiega perché ceppi diversi di kratom possano produrre effetti percepiti come differenti.
Il meccanismo d’azione di questi alcaloidi è interessante e atipico. Essi agiscono primariamente come ligandi dei recettori oppioidi del sistema nervoso centrale, in particolare i recettori μ (mu), δ (delta) e κ (kappa). Tuttavia, la loro interazione è qualitativamente diversa da quella degli oppioidi classici come la morfina. La mitraginina, ad esempio, è un agonista parziale dei recettori μ-oppioidi: ciò significa che attiva il recettore, ma in misura minore rispetto a un agonista completo. Inoltre, la ricerca suggerisce che la mitraginina non recluti in modo efficiente una proteina chiamata β-arrestina 2, responsabile di alcuni degli effetti collaterali degli oppioidi classici, come la depressione respiratoria (la causa più comune di overdose) e lo sviluppo di una forte dipendenza. L’attività “biased” o “parziale” degli alcaloidi del kratom potrebbe quindi spiegare il suo profilo di sicurezza apparentemente più favorevole, sebbene non privo di rischi.
La complessità farmacologica del kratom si distingue nettamente da quella di altri composti vegetali noti. Ad esempio, il cannabidiolo, il principale composto non psicoattivo della cannabis light, agisce influenzando il sistema endocannabinoide, un sistema di segnalazione cellulare completamente diverso.
Non dimentichiamo che ogni pianta possiede un’impronta chimica unica con meccanismi d’azione specifici. La dualità del kratom (stimolante a basse dosi, sedativo ad alte dosi) può essere spiegata anche da questa complessità recettoriale: a basse concentrazioni, potrebbero prevalere le interazioni con altri sistemi, come i recettori adrenergici (simili all’adrenalina), mentre ad alte dosi diventa dominante l’azione sui recettori μ-oppioidi, portando a sedazione e analgesia.


Il kratom oggi: usi moderni, dibattiti e quadro normativo
L’esportazione del kratom dal Sud-est asiatico al mondo occidentale ha trasformato le sue modalità di consumo e la sua percezione. Se tradizionalmente si masticavano foglie fresche o si beveva un tè, oggi il mercato globale offre prevalentemente kratom in polvere (ottenuta da foglie essiccate e macinate), capsule e, sempre più spesso, estratti liquidi o resine altamente concentrati. Queste nuove formulazioni presentano alcuni problemi da risolvere: la polverizzazione e la concentrazione possono alterare il profilo chimico e rendere più difficile il dosaggio, aumentando il rischio di effetti avversi o di sviluppo di tolleranza e dipendenza. La mancanza di standardizzazione e di controlli di qualità nel mercato non regolamentato è una delle maggiori preoccupazioni per la salute pubblica, con rischi di contaminazione da metalli pesanti, salmonella o adulterazione con altre sostanze.
Questo scenario ha alimentato un acceso dibattito a livello internazionale. Da un lato, organizzazioni di consumatori e alcuni ricercatori ne evidenziano il potenziale come alternativa a farmaci antidolorifici più rischiosi o come strumento per la gestione dell’astinenza da oppioidi. Dall’altro, agenzie regolatorie come la Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti hanno espresso serie preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza, citando casi di tossicità epatica, convulsioni e dipendenza, e sottolineando la mancanza di studi clinici robusti sull’uomo che ne convalidino l’efficacia e la sicurezza. Questa polarizzazione rende difficile un dialogo equilibrato.
Il quadro normativo del kratom è di conseguenza in continua evoluzione. In molti dei suoi paesi d’origine, come la Thailandia, dopo decenni di proibizionismo, si sta assistendo a una riconsiderazione, con una parziale legalizzazione per uso medico e tradizionale. In Europa e nel mondo, la situazione è eterogenea: è illegale in diversi paesi (tra cui l’Italia, dove è inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti), mentre in altri si trova in una zona grigia o è legale.
Questa frammentazione ricorda da vicino il percorso normativo che ha interessato la cannabis legale. In alcuni Paesi la legge consente la vendita e l’uso di prodotti come la canapa light, derivati da varietà di canapa sativa con un contenuto di THC entro i limiti di legge. In altri, invece, la vendita è consentita sotto sotto forma di preparati farmaceutici e cosmetici.
Un confronto tra kratom e cannabis
Il paragone tra il kratom e la cannabis light può essere un punto di interesse per molte persone interessate al tema. Sebbene le loro differenze a livello botanico, chimico e di impatto sull’organismo siano sostanziali, entrambe le piante hanno una lunga storia di utilizzo tradizionale e, in tempi recenti, hanno acquisito una notevole popolarità in Occidente per scopi diversi. Detto questo, è fondamentale comprendere che si tratta di due entità distinte, ciascuna con i propri specifici meccanismi d’azione e profili di legalità.
Mentre la cannabis light è apprezzata principalmente per la presenza di CBD e altri cannabinoidi che interagiscono con il sistema endocannabinoide, il kratom agisce diversamente (come abbiamo visto). Il CBD, in particolare, non produce effetti psicoattivi significativi, ma è oggetto di studio per le sue potenziali proprietà.
L’uso tradizionale del kratom, come abbiamo visto, ha radici profonde nella cultura del Sud-Est asiatico, mentre la cannabis ha una storia di utilizzo più ampio, che in modi e in tempi diversi ha coinvolto tutto il mondo. Pertanto, l’accostamento tra le due deve essere fatto con cautela, sottolineando la diversità dei principi attivi e delle finalità d’uso. Nonostante entrambe siano di origine vegetale e godano di un certo interesse da parte di chi cerca alternative naturali, i loro percorsi biochimici e gli effetti non sono affatto sovrapponibili. Come al solito, prudenza e l’informazione sono elementi chiave per chi si approccia a questo argomento.
Leggi anche: Pane con farina di canapa: come viene preparato e quali sono gli effetti di questo alimento
Il kratom tra potenziale e prudenza
Giunti al termine di questa analisi, possiamo dire che il kratom è come una sostanza botanica di straordinaria complessità che oscilla tra una visione etnobotanica millenaria e le frontiere della farmacologia moderna. La sua storia, radicata nelle tradizioni lavorative del Sud-est asiatico, ci offre uno spaccato di come le piante possano avere un ruolo sociale oltre che “curativo”,
La sua duplice natura, stimolante a basse dosi e sedativa ad alte dosi, è una diretta conseguenza della sua ricca composizione di alcaloidi e della loro peculiare interazione con i sistemi recettoriali umani, un meccanismo che la scienza sta solo ora iniziando a comprendere pienamente.
È innegabile che il kratom possegga un potenziale farmacologico che merita un’indagine scientifica seria e imparziale. Gli studi preliminari sulla sua capacità di agire sui recettori oppioidi con un meccanismo “biased” aprono prospettive interessanti per lo sviluppo di nuovi analgesici con un profilo di rischio potenzialmente ridotto. “Potenziale”, però, non è sinonimo di “provato” né di “sicuro”. L’assenza di studi clinici controllati su larga scala sull’uomo lascia aperti numerosi interrogativi sulla sua sicurezza a lungo termine, sulle interazioni farmacologiche e sul suo reale potenziale di dipendenza, specialmente con le formulazioni concentrate moderne. La prudenza è, quindi, non solo consigliabile, ma assolutamente necessaria.
Il dibattito che circonda il kratom riflette una più ampia discussione culturale sull’uso delle sostanze naturali in un mondo dominato dalla farmaceutica sintetica. Proprio come è avvenuto per il CBD e l’olio di CBD, derivati dalla canapa sativa, la cui popolarità ha spinto la ricerca e la regolamentazione a evolversi, anche per il kratom il futuro dipenderà da un approccio equilibrato, che da un lato non ne demonizzi a priori l’uso, riconoscendone la storia e il potenziale, e dall’altro non ne minimizzi i rischi, promuovendo una regolamentazione chiara, standard di qualità rigorosi e, soprattutto, una ricerca scientifica indipendente e di alta qualità.
La conoscenza, come al solito, ci aiuterà: comprendere la pianta, la sua storia, la sua chimica e il contesto legale è il primo, fondamentale passo per capire le potenzialità e i rischi del kratom con consapevolezza e responsabilità.
Vuoi restare sempre aggiornato sulla cannabis light e temi analoghi? Continua a leggere gli articoli del blog di Just Bob.
Il kratom spiegato bene: takeaways
- Il kratom, noto scientificamente come Mitragyna speciosa, è un albero della stessa famiglia del caffè originario del Sud-est asiatico, le cui foglie sono state usate per secoli dalle popolazioni locali per i loro effetti stimolanti a basse dosi e sedativi ad alte dosi;
- La sua azione farmacologica è legata a specifici alcaloidi, in particolare la mitraginina e la 7-idrossimitraginina, che agiscono sui recettori oppioidi in modo diverso dagli oppioidi classici, ma la loro efficacia e sicurezza a lungo termine richiedono ancora un approfondimento scientifico;
- Oggi il dibattito sul kratom è acceso e complesso, con un quadro normativo frammentato a livello globale che si confronta con l’aumento delle nuove formulazioni in polvere e concentrate, le quali possono aumentare i rischi d’uso a causa della loro maggiore potenza e mancanza di standardizzazione.
Il kratom spiegato bene: FAQ
Che cos’è il kratom e qual è la sua origine?
Il kratom, scientificamente noto come Mitragyna speciosa, è un albero sempreverde originario del Sud-est asiatico, appartenente alla famiglia delle Rubiaceae, la stessa del caffè. Le sue foglie sono state utilizzate per secoli nelle culture tradizionali di Thailandia, Malesia e Indonesia per le loro proprietà stimolanti a basse dosi e sedative ad alte dosi.
Quali sono i principali alcaloidi del kratom e come agiscono?
I principali alcaloidi del kratom sono la mitraginina e la 7-idrossimitraginina. Questi composti agiscono principalmente sui recettori oppioidi del sistema nervoso centrale, ma con un meccanismo diverso dagli oppioidi classici. La mitraginina, ad esempio, è un agonista parziale dei recettori μ-oppioidi, il che potrebbe spiegare un profilo di sicurezza apparentemente più favorevole.
Qual è il quadro normativo del kratom in Italia e nel mondo?
Il kratom è illegale in Italia, dove è inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti. A livello globale, la sua regolamentazione è eterogenea: alcuni paesi lo vietano, altri lo consentono per uso tradizionale o medico, e altri ancora lo lasciano in una zona grigia. La mancanza di standardizzazione e controlli di qualità rappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica.